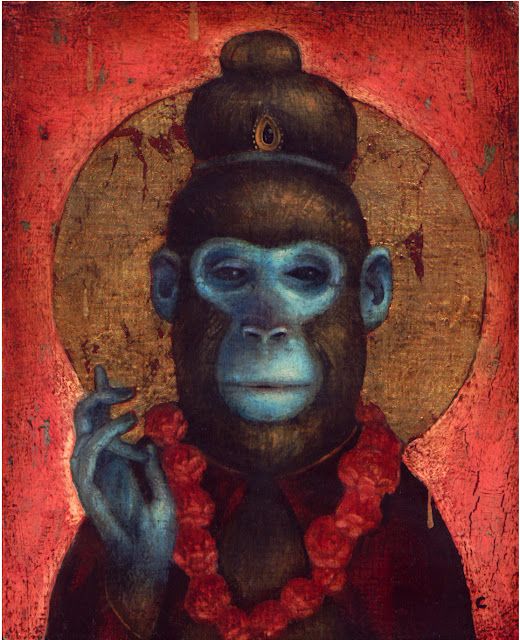I molteplici stati di coscienza nello Yoga e nello sciamanesimo
di Pio Filippanio Ronconi
Qualsiasi studio che si proponga di sceverare la natura, le tecniche, i fini e le tappe progressive dello Yoga, come anche di quell’insieme di pratiche e di riti estatiche caratterizzano lo Sciamanesimo, si troverà di fronte alla difficoltà di superare il limite puramente descrittivo, ad esempio degli anga dello Yoga o delle fasi di iniziazione e della pratica sciamanica, che ben poco possono rivelare circa la realtà intima – il Wesen – del sistema esoterico o estatico preso in esame.
Si tratta di un problema epistemologico: per intendere questo elemento, che costituisce lo scenario interiore sul quale lo sciamano compie le sue pratiche, occorre penetrare imaginativamente negli stati di coscienza nei lo yogin, il mago” o lo sciamano s’immerge lucido e vegliante, e intendere il rapporto fra questi stati di coscienza – che ritroviamo descritti in una miriade di opere dagli Yogasûtra di Patanjali fino ai Tantra saiva, vaisnava o sâkta – e il mondo obiettivo spazio-temporale di veglia, per intenderci, quello stesso che viene apparentemente trasceso e messo da parte durante l’impresa estatica, dato che ad un certo momento, alla fine del rito o dell’evocazione, il “portento” si verifica proprio nel comune ambito spazio-temporale e su questo lo si recepisce.
A tale proposito, si può osservare che anziché trattarsi di uno spazio-scenario passivo, quello dello yogin o dello sciamano scaturisce dalla volontà stessa dell’operatore, quella di personificarsi “qui” o “là”, “in questo tempo” o “in quell’altro”, presente o futuro. Lo yogin e, in parte, lo sciamano possono operare sulle cose perché percepiscono il pensiero con cui se le rappresentano, cioè il pensiero “magico” dello yogin viene foggiato dalle discipline del pratyâhara (la abstractio delle facoltà di percezione dallo strumento sensorio), del dhârana (cioè la concentrazione mentale) e del dhyâna (la meditazione estatica).
Si tratta di un problema eminentemente epistemologico, di cui, fra tutte le tradizioni sapienziali, quella dell’India può offrirci la chiave d’interpretazione, poiché in India si è conservato fino al giorno d’oggi e trasmesso in un rigoroso linguaggio filosofico il retaggio di almeno due civiltà, quella postulata come indomediterranea, che si continua ai giorni nostri nella cultura dei tantra e delle sette gnostiche in generale, e quelle del filone vedico che, pur se ridotto ed adattato a nuove esigenze religiose, si perpetua come liturgia nella religioni dell’India e, come fonte autorevole, nella “filosofia dei sei sistemi”, i darsana. Per fare un paragone, è come se, accanto alla filosofia positiva dei Greci si fosse conservata fino ai giorni nostri la sapienza dei Misteri dell’antichità, trascritta in un linguaggio mistico-matematico.
Non soltanto, ma questa “meditazione filosofica” volta alla realizzazione spirituale può, in seguito a recenti studi, vantare una doppia genealogia: quella vedica su accennata, fondata sul culto delle divinità maschili e luminose, che simboleggiano – a livello della meditazione estatica – i poteri luminosi della coscienza, il cui culto sarebbe stato importato in India dalla migrazione arya, e , di fronte a questa, quella che amiamo definire “indomediterranea” per la sua somiglianza con i culti e i misteri della nostra antichità pre-classica, che ha al suo centro puri poteri numinosi personificati nei cosiddetti asura, che nella successiva tradizione indiana diventano semplicemente i démoni anti-deva, le cui imprese e sconfitte ad opera dei deva e degli eroi dell’epica (vedi il Ramâyana, il Mahâbhârata, ecc.) sono alla base della gigantesca mitologia indiana.
E proprio a questi secondi dèi, relegati ad una funzione negativa rispetto ai deva aryi, risale tradizionalmente l’insegnamento ascetico ad esempio del Jainismo, i cui varii Tirthankara, cioè Pontefici, risalgono ad oltre l’850 a.C., data del penultimo di essi, Pârsva, seguito dal Jina nel VI sec. a.C. Anche l’epopea ariana dei Purâna e del Mahâbhârata, a tacere del Râmâyana, serba rispettoso ricordo di questi anti-dèi che regnavano nel sud non-ariano quali, di contro ai deva, possedevano la âtma-vidyâ, la “scienza del sé stesso”, […].
“Dopo la loro sconfitta, Indra il signore degli Âryi chiese ai re Asura Bali, Namuci e Prahlâda: ‘Il vostro regno è stato conquistato, voi siete nelle mani dei vostri nemici, eppure sul vostro volto non vi è traccia di dolore. Quale ne è la ragione?’. Bali, signore dell’âtma-vidyâ, figlio di Virocana, rispose in modo tale da scuotere l’orgoglio di Indra: “O Signore dei Signori! Sono sorpreso dalla tua follia. Adesso tu prosperi e la mia fortuna mi è stata sottratta, ma non si conviene che lodi te stesso di fronte a me’”. (1)
Dal punto di vista storico, il fatto che nell’antichissimo Rg-veda si trovino menzionati alcuni termini denotanti asceti non appartenenti strettamente alla tradizione aryo-vedica, come vatarasana-muni, in alternativa a vatarasana- sramana, Kesin (“dalla lunga chioma”, detto dei maghi volanti a cagione del calore ascetico, il tapas da loro sprigionato, cfr. Rg-veda X, 136), Vrâtya e Arhat, dimostra che la tradizione sramana è con ogni probabilità anteriore a quella introdotta dagli Aryi con i Veda. Si potrebbe anche postulare un rapporto, se non altro tecnico – per la pratica dell’estasi e la realizzazione degli stati superiori della coscienza – con alcune specie di sciamanesimo praticato in Asia Orientale, data anche la coincidenza onomastica di saman con sramana, quest’ultimo derivato dal verbo všram = adoprarsi, affaticarsi. (2)
Le tappe della realizzazione interiore del myste, muni o sramana che sia sono accompagnate dalla penetrazione negli strati più profondi della coscienza, laddove egli attua la propria identità con le potenze che reggono, su di un’ottava cosmica, i processi della volontà, quelli stessi che, al livello fisico-sensibile, cui corrisponde la coscienza di veglia, sovraintendono nella compagine umana alle funzioni del ricambio, del movimento nello spazio e della generazione. La capacità, per esempio, che ha uno sciamano di compiere portenti che apparentemente vìolano le leggi della materialità ordinaria dipende dalla sua identificazione – la sua adaequatio, anubhava si direbbe in sanscrito (“diventare la cosa meditata”) – con quel livello di realtà che è soggettivamente un livello di coscienza.
La tradizione indiana, alla quale si è fatto riferimento, annovera quattro livelli di coscienza, che vengono simbolicamente riferiti ad altrettanti momenti dell’articolazione del verbo creatore espresso con il fonema OM (cioè AUM). La Mândukya Upanisad (Upanisad trad. Filippani Ronconi, Boringhieri 1974 III ed., pagg. 527 ss.), che qui cercheremo di riassumere con le parole stesse dell’Autore, così descrive i molteplici stati di coscienza e le corrispondenti condizioni ontologiche:
“Om è questo indefettibile brahman, Om è tutto ciò che è; questa Upanisad ne è la spiegazione. Ciò che è esistito, ciò che esiste e ciò che esisterà, tutto ciò è compreso nella Om. Quell’altro, trascendente la tritemporalità, è pur esso designato da Om.
Tutto ciò che è, è invero il brahman (lo spirito universale); questo âtman (lo spirito individuale) è il brahman; questo âtman ha quattro stati (catuspat, “quattro piedi”).
La prima condizione è Vaisvânara (“comune a tutti gli uomini”), la quale ha come sede lo stato di veglia (jagarita-sthâna); essa ha conoscenza degli oggetti esteriori; ha sette membra, diciannove volti (3) e fruisce del mondo materiale.
La seconda condizione è Taijasa (“sostanziata di luce”, tejas), la cui sede è lo stato di sogno (svapna): essa ha conoscenza degli oggetti interiori; ha sette membra e diciannove bocche ed ha come dominio il mondo della manifestazione sottile.
Allorchè l’essere dormiente non prova più desideri, non è più soggetto a sogni, allora si ha la condizione di sonno profondo (susupta). Colui che si è identificato a questo stato (eki-bhuta) è divenuto sintesi di conoscenza, (prajñana-ghana), si è fatto beatitudine (ânanda-maya) ed ha la beatitudine come campo di esperienza: la coscienza è il suo strumento di conoscenza. Costui è chiamato prajña (“conoscitore assoluto”). Questa è la terza condizione.
Egli è il Signore di tutto, Egli è l’onnisciente; Egli è l’ordinatore interno, matrice del tutto. Egli è l’origine e la fine di tutti gli esistenti.
I saggi pensano che il Quarto che non ha conoscenza né degli oggetti interni né di quelli esterni, né, contemporaneamente, di questi e di quelli, che non è sintesi di conoscenza, poiché non è né conoscente né non conoscente, che è invisibile, non agente, incomprensibile, indefinibile, impensabile, indescrivibile, è la sicura essenza fondamentale dell’âtman, nel quale è totalmente cessata ogni traccia di manifestazione, ed è pienezza di pace e di beatitudine, senza dualità; questo è l’âtman (così deve venir conosciuto).
Egli è l’âtman: riguardo alle lettere è super indefettibile, designato da Om, riguardo alla cui misure (adhi-mâtra) ogni piede del brahman corrisponde ad ogni sua misura, ogni misura sua ad ogni piede del brahman: questi piedi sono le lettere A, U, M.
Vaisvânara, la cui sede è lo stato di veglia, è designato dalla lettera A, che è la prima misura (mâtra) del monosillabo Om per il fatto che âpti (“connessione” fra i dati dell’esperienza sensibile) inizia con A. Colui che così conosca consegue (âpnoti) tutti gli oggetti di desiderio ed è il primo (âdi) in ogni impresa.
Taijasa, la cui sede è lo stato di sogno, è designato dalla lettera U, che è la seconda misura, in quanto utkarsa (“elevazione”) rispetto alla dualità di mondo materiale e mondo sottile (suksma): esso, invero, sublima (utkarsati) il flusso ininterrotto di conoscenza (jñâna-santati). Colui il quale ciò conosca è in armonia con il Tutto; non uno dei suoi discendenti ignorerà il brahman.
Prajña, la cui sede è lo stato di sonno profondo, è designato dalla lettera M, che è la terza misura, in quanto determina (miti) la “dissoluzione” (apîti, cioè la lisi della conoscenza oggettiva). Colui il quale ciò conosce diventa invero onnipenetrante.
Il Quarto stato (caturtha) è incommensurabile (a-mâtra, in quanto non soggetto ad esperienza), è non-agente, è al di là della manifestazione; esso è assoluta calma (siva) e trascende la condizione di soggetto ed oggetto. Tale è la lettera Om. Colui il quale così conosca diventa puro âtman (“individuo assoluto”) e, mediante l’âtman (“il sé”) penetra nell’ âtman (“sé come spirito universale”).”
Ora, in particolare, il Quarto stato, al quale corrisponde l’esperienza (vegliante!) della catalessi, non si somma ai precedenti tre stati come loro ultimo, bensì è immanente in ognuno di loro, come atto di pura autoconoscenza nella realizzata identità di âtman e di brahman, di spirito incarnato e di spirito universale.
Dal punto di vista metafisico, in riassunto, si tratta di ciò:
Il brahman, uscendo dalla sua assolutezza per una sorta di gioco magico – la mâyâ , substrato dell’“Illusione” esistenziale – si attua estravertendosi in quattro diversi livelli di conoscenza, ognuno dei quali contiene in potenza i successivi: l’Essere puro identico a sé stesso corrispondente al quarto stato; il Verbo (Vâk, Para-sabda), come causa, kârana, attraverso le sedici vocali, forme a priori delle sue infinite potenze (sakti) di manifestazione, cui corrisponde nell’uomo ordinario lo stato di sonno profondo; al livello invece di sonno con sogni corrisponde il piano delle forze sottili, suksma, come le forze psicofisiche dell’energia vitale volte verso la manifestazione del mondo su piano materiale, sthula.
Dallo Spirito del Mondo, Mahân âtma, già “inespresso”, avyakta, possibilità di manifestazione in generale, discende la Psiche, Buddhi, che come Colonna di Luce connette il mondo dello spirito con l’anima dell’uomo, nella quale essa si individua come esperienza pensante (manas) ed esperienza riflessa dell’io (ahamkâra). Attorno a queste categorie si organizzano gli strumenti della percezione sensoria (nuddhîndriya), in dipendenza delle rispettive facoltà (karmêndriya) da cui gli universali della Natura obiettivata (tan-mâtra), le quidditates che, alla loro volta, danno luogo agli elementi “fisici”.
In pratica il mondo oggettivo esteriore viene dedotto dallo Spirito Universale interiormente intuito, per cui alla fine dei conti tutto i mondo che si dispiega dinanzi ai nostri sensi è un epifenomeno dello stesso spirito che se lo rappresenta! Questo metafisicamente spiega come i pensiero tradizionale, deducendo il mondo manifesto dallo Spirito che, in ultima analisi, è quello che se lo rappresenta, ammetta di poter operare su quello “magicamente”, partendo dalle facoltà interiori di rappresentazione e di volontà. Queste facoltà operano su diversi piani a seconda dell’energia che la volontà cosciente del praticante mette in funzione.
Di là dal potere logico-discorsivo che coglie il mondo paralizzato nella sua parvenza “minerale” sulla dimensione spazio-temporale, a livello di sogno si ha l’immaginazione, che sperimenta il mondo nella sua realtà di energia pura su di una dimensione di “durata”, cioè di sintesi temporale, non ancora frantumata nella successione degli “attimi” (anu); di là da questa, a livello di sonno profondo, l’asceta sperimenta il mondo come pura “sonorità” (nâda), che si rifrange nelle sedici “vocali” (svâra), “vesti di potenza” dell’assoluto (sakti, le “piccole madri”, mâtrikas, della realtà), il quale costituisce la “quarta” dimensione della realtà, essenziata di pura coscienza autoluminosa (prabhâsvaram cittam), pura immanenza in tutte le possibili forme di coscienza.
Questa concezione relativa alla molteplicità degli stati di coscienza, che fra l’altro è eminentemente sviluppata nella letteratura tantrica dell’India, costituisce la base per la speculazione e la pratica dell’ascesi mahâyâna in India e nel Tibet, con un riflesso immediato sullo sciamanesimo Bon-po, che ne ha pienamente accolto la teoria.
Questa esperienza, più che teoria, dei quattro stati di coscienza è, in pratica, il fondamento epistemologico su cui si basa la meditazione filosofica indiana (anviksiki), volta non tanto a raggiungere una spiegazione logica dell’Universo e della nostra esistenza in esso, quanto a sperimentare concretamente il suo significato e la sua efficienza, al fine di ottenere la “liberazione in vita” (jivân-mukti); liberazione da un’esistenza condizionata dall’Ignoranza (avidyâ), dal dolore (duhkha), malattia e morte.
Ma anche, indipendentemente dal caso del vîra, l’“eroe” che nella pratica dello yoga si propone di conseguire la libertà da tutti i vincoli e l’immortalità, la penetrazione cosciente e desta nei livelli in cui l’uomo comune, il pâsu (l’animale), si assopisce perdendo il senso dell’”io sono”, è la condizione imprenscindibile anche per l’asceta meno qualificato che miri a conseguire le siddhi, i poteri magici.
A questo punto si può formulare l’ ipotesi che tutte quelle tecniche psicofisiche, che caratterizzano le varie Religiones Secundae come lo Sciamanesimo, le forme popolari del Tao-chiao, i culti estatici, che vegetano come forme crepuscolari liturgico-devozionali accanto alle grandi religioni, ad esempio i vari ordini di dervisci nell’Islam (specialmente i Mevlevî ed i Bektashî), attingano quel sapere frammentario ed evanescente che guida le loro pratiche da una remota esperienza di quell’insieme di discipline, le quali nella loro interezza sono tuttora il retaggio curato e filosoficamente giustificato dello Yoga classico e delle altre forme della medesima disciplina che ci sono state trasmesse dai Tantra sia hindu che buddhisti, dagli Âgama dello Saiva-siddhânta e dal Vajra-yâna mahâyânico. Per loro si tratta di discendere – giovandosi di vari appigli psicofisici: concentrazione mentale su adatti monoideismi e stati alterati di coscienza dovuti ad ingestione di funghi, fumo prolungato, consumo di droghe, ecc. – ad un livello di coscienza profonda profondo, che non è semplicemente mentale, bensì implica differenti dimensioni oggettivamente e strumentali, e su di esso sperimentare non passivamente un’alterazione dell’”appoggio”, se non addirittura ciò che nel Mahâyâna si denomina “la revulsione dell’appoggio”, âsraya-parâvrtti, per cui i rapporto con la realtà fisico-sensibile è causato non più da un passivo determinismo che l’asceta subisce, bensì da una diversa causalità a cui lo sciamano ha accesso. Si tratta, per dirla semplicemente, di animare i poteri dell’immaginazione (non “fantasia”!) sul livello a cui l’uomo comune si assopisce, dell’ispirazione, al livello (per gli altri!) di sonno profondo, ove operano le potenze della volontà con un percorso opposto a quello del pensiero ordinario, e, infine, dell’intuizione, al livello di catalessi, laddove si attua, di là da qualunque possibile cogitazione, l’identità fra soggetto ed oggetto dell’esperienza, la cosmica epopteia (4) dei Misteri antichi.
Fin qui si è cercato di tratteggiare alcuni caratteri psicologici di coincidenza fra lo Yoga e lo Sciamanesimo, per cui rimane il dubbio se alcune forme di Yoga non “classico”, che da millenni si perpetuano nelle scuole settarie, non rappresentino lo sviluppo ambientale di alcune branche di sciamanesimo antico, la cui arcaicità può risalire alla scoperta della fusione dei metalli, data l’importanza, positiva o negativa (vedasi la maledizione contro la professione di fabbro presso i Berberi di contro la posizione quasi regale del fabbro tra Altaici, Malesi ed Estremo-orientali), che assume l’armamentario metallico presso gli Sciamani. Questo potrebbe essere oggetto di uno studio approfondito di natura tecnica, antropologica, sociale, ecc.
Volendo riassumere i caratteri più specificamente comuni delle varie specie di Sciamanesimo si potrà dire che essi sono quelli relativi all’estasi, all’entrata in condizioni non usuali di consapevolezza, allo sviluppo di facoltà extrasensoriali e dei poteri ad esse connessi (siddhi, mna), ciò che ci riporta al tema dei molteplici stati di coscienza che sono alla base dello Yoga, sia quello “classico” che quello praticato dalle numerose sétte gnostiche in India e nel Tibet. Nell’ambito del Vajrayâna e delle scuole da questo derivate nel Tibet (Sahaja-yâna e Kâla-cakra) tali esperienze, che in pratica rivelano diverse dimensioni dell’esperienza cosciente, acquistano una specie di status ontologico, ipostatizzandosi nella triplice ottava di corpo-verbo-mente (kâya, vâk, citta), che corrisponde ai primi tre stati di coscienza postulati, come detto sopra, dalla Mândukya Upanisad o, nell’ambito strettamente soteriologico, dalla realizzazione della quadruplice mudrâ, o dal quadruplice vuoto mediato dall’âsraya-parâvrtti, la “revulsione” dell’appoggio dato dall’esperienza sensibile del mondo, la quale “revulsione” conduce alla realizzazione del vuoto (sûnyata, tib. ston-pa-ñid) di là dal mondo dell’Illusione esistenziale (mâyâ, tib. Sgyu-maán, ak’rul-snán).
A voler riassumere, a parte la chiesa Bon-po, che ha assorbito i criteri fondamentali dell’avversario Buddhismo e si è perciò organizzata e sistematizzata, lo Sciamanesimo presenta l’immagine di un sapere estremamente arcaico, proprio ad una remotissima cultura, ormai crepuscolare, proprio perché si è rarefatto i tipo umano che la sostentava, per i quale era ancora naturale l’accesso in diverse condizioni spirituali, nelle quali l’uomo odierno – assiato su di un’esperienza astratta della realtà – perde la coscienza. Si tratta di una fase culturale per la quale diciannove secoli fa Plutarco di Cheronea constatava smarrito la “morte del grande Pan”.
Sulle ali della nostalgia per una sapienza prossima ad estinguersi e pur tuttora vivente fra rade popolazioni disperse, lungi dai percorsi della civiltà moderna, si perpetua ancor oggi la mistica tradizione dei poteri dell’anima ai quali l’iniziazione schiude l’accesso. Si tratta essenzialmente di discendere con rinvigorita consapevolezza negli stati di coscienza medesimi, nei quali la vigile presenza dell’”io” si attenua e sparisce presso l’uomo comune, mentre per l’iniziato si accende nell’acquisto di conoscenze che sono contemporaneamente poteri; primo tra tutti il mistico calore, il tapas, già mentovato nel Rg-veda (X, 136), il tibetano gtun-mo, che permette di trascendere i limiti spaziali e temporali, indi le sei siddhi elencate nei tantra della “mano sinistra” (scrt. Vâma-cara). E’ il mondo delle kha-carînî (tib. mkha agro), le “viaggiatrici nello spazio” dotate di miracolosa e temibile potenza (si pensi alle nostrane streghe volanti attorno al famoso Noce di Benevento).
Resta il dubbio che la condizione animica della “entrata in phronesis” (scrt. Krodha-âvesa, tib. khro-ba), disciplina individuale che permette lo sciogliersi dalla coscienza legata alla percezione del mondo materiale, non sia altro che una “irruzione di stati pre-individuali” con il loro naturale carico astrale nella coscienza di veglia, condizione ben conosciuta nei Tantra ai quali si è alluso più sopra. Degenerazioni di questa pratica possono essere gli stati di amok e di lalat ben conosciuti tra le popolazioni malesi ed indonesiane. Discipline volte alla realizzazione di questa specie di wut sciamanico potrebbero anche essere il furu-tama ed il funa-koshi, praticati in alcune arti marziali giapponesi.
(1) Acharya Shri Tuls: Prevedic existence of sramana tradition, XXVI International Congress of Orientalists, New Delhi, 4-1-1964)
(2) Il termine prototurco dovrebbe essere a rigore kami (non si dimentichi che in giapponese kami sono propriamente gli “spiriti”), mentre il mago con funzione regale è detto bek, bekki.
(3) le sette membra cono i sette strumenti dell’azione: il mentale, il sole e la luna (corrispondenti ai due occhi), il fuoco (il soffio vitale della bocca), le direzioni dello spazio (l’orecchio), l’atmosfera (i polmoni), l’etere ove sono foggiate le forme (lo stomaco che elabora il cibo per l’accrescimento del corpo), la terra (il corpo umano come materia); le diciannove bocche sono gli strumenti dell’esperienza: i cinque organi di percezione, le cinque facoltà di azione, i cinque soffi vitali, il mentale, l’intelletto, il pensiero associato, l’organo dell’egoità.
(4) cioè: contemplazione, il più alto livello nell’iniziazione ai Misteri Eleusini.
Tratto da: Simmetria.org